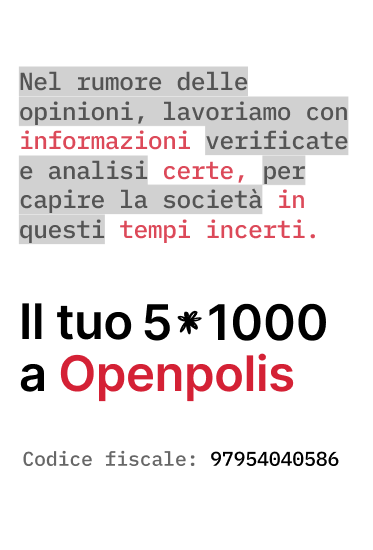Il nostro diritto digitale alla città
1. Introduzione
di openpolis
Quella digitale non è più – se mai lo è stata – una dimensione aggiuntiva, separata o virtuale della vita: è parte del quotidiano di ognuno di noi e del modo in cui viviamo insieme agli altri la città. I dati – quelli che produciamo con i nostri smartphone e quelli amministrativi – rappresentano la posta in gioco per il controllo delle trasformazioni che attraversano la società e le città in particolare. Di conseguenza garantire l’accesso ai dati e le competenze necessarie per utilizzarli sono diventate condizioni determinanti per poter prendere parte alle trasformazioni in atto, invece di limitarci a subirle.
Scarica il libro gratuitamente o richiedine una copia stampata .
Il merito principale di questo libretto è offrire degli spunti di analisi critica di queste trasformazioni e suggerire come le rivendicazioni dei diritti e le lotte politiche devono avvenire tanto nelle città di mattoni e cemento quanto nelle loro rappresentazioni digitali. Materiale e immateriale sono aspetti inestricabili e interconnessi della stessa realtà, tanto quanto lo sono la mappa digitale del navigatore e le strade su cui oggi camminiamo e domani verremo trasportati da un veicolo senza pilota (umano). Ed è per questa ragione che pensiamo che la traduzione in italiano di questo libretto sia un’operazione necessaria. Malgrado gli autori facciano parte di università di paesi di area (e cultura) anglosassone, l’approccio e le trattazioni sono tutt’altro che accademici.
A guidare è il lo stile agile e dichiaratamente provocatorio del pamphlet per rivolgersi al di fuori delle nicchie degli esperti e chiamare alla mobilitazione e suscitare dibattiti nelle città
Le istantanee che vengono scattate catturano solo pochi tratti del paesaggio in trasformazione, alcuni più significativi altri forse meno – soprattutto nel contesto italiano – ma rivelano movimenti di fondo. Vale la pena quindi sottolinearne alcuni e aggiungere brevemente qualche spunto specificamente riferito al nostro paese. C’è innanzitutto la necessità di sfatare alcuni luoghi comuni fortemente ideologici. Uno è quello della veridicità intrinseca dei dati, come se riportare un dato equivalesse a rivelare una verità. Dall’ideologia dei dati discende poi quella della oggettività e imparzialità delle decisioni basate sui dati, decisioni che sempre più spesso vengono affidate agli algoritmi. I dati, invece, non ci possono fornire altro se non una delle possibili versioni della realtà, tanto più affidabile quanto più i dati sono di qualità e quanto più è valido il modello in base al quale i dati vengono elaborati. I dati, potremmo dire, sono sempre politici come le mappe.
Altro mito e parola chiave dei nostri tempi digitali è quello della trasparenza che, guarda caso, viene sempre usata riguardo ai dati pubblici – quelli raccolti dalle pubbliche amministrazioni – che giustamente devono essere aperti e resi disponibili.
Mai invece questioni di trasparenza vengono poste nei confronti delle grandi corporation proprietarie delle piattaforme che raccolgono dati di ogni tipo – in particolare dei cittadini e sui cittadini – e in quantità spesso maggiori a quelle dei governi. Non si tratta qui di cedere alla seduzione negativa delle suggestioni distopiche, piuttosto di immaginare vie di fuga da scenari in cui le trasformazioni tecnologiche creano chiusure monopolistiche e progressive recinzioni, invece che aperture continue e benefici distribuiti come prometteva l’internet delle origini.
Sotto il profilo economico si tratterebbe di immaginare forme di regolamentazione dei mercati per assicurare la concorrenza ed impedire il consolidamento dei monopoli in ambiti particolari come quelli dell’informazione, della comunicazione sociale e della conoscenza.
Occorre definire in maniera progressiva un diritto all’accesso e all’uso dei dati di interesse sociale raccolti anche dalle piattaforme proprietarie, a favore di un loro riutilizzo a beneficio della collettività
Sotto quello giuridico occorre definire in maniera progressiva un diritto all’accesso e all’uso dei dati di interesse sociale – opportunamente anonimizzati – raccolti anche dalle piattaforme proprietarie, a favore di un loro riutilizzo a beneficio della collettività (in fin dei conti si tratterebbe di una forma di restituzione).
Per dirne una, i dati raccolti e trattati da Waze (1), che provengono dagli abitanti della città, potrebbero essere riusati – in modo e forme da stabilire – dalle amministrazioni cittadine per migliorare la mobilità degli abitanti stessi, oltreché per il profitto dei proprietari della piattaforma.
Questi e altri spunti potrebbero essere aggiunti e opportunamente approfonditi ma qui vale la pena riprendere e rilanciare il punto che è al cuore della concezione del diritto alla città: che siano coloro che usano la città a disegnare il progetto di città che vogliono abitare.
Le politiche di open data per la trasparenza e la partecipazione – in Italia forse più che altrove – producono adempimenti amministrativi senza produrre trasparenza o partecipazione, perché sono concessioni dall’alto e non guidate da una reale domanda sociale. Non può esserci trasparenza se non c’è qualcuno che, dall’esterno, sappia guardare dentro le finestre che vengono aperte; qualcuno che sia in grado di fare domande e chiedere conto. In qualche modo il diritto digitale alla città ci dice che solo quando si diventa produttori attivi di dati si può essere anche utilizzatori consapevoli dei dati stessi, perché vuol dire che si hanno un disegno e una direzione da seguire insieme ad altri; cose che sono molto importanti per usare i dati e le tecnologie invece che esserne usati.
Note:
(1) Waze è un’applicazione che sfrutta la posizione degli utenti per fornire informazioni sul traffico in tempo reale.