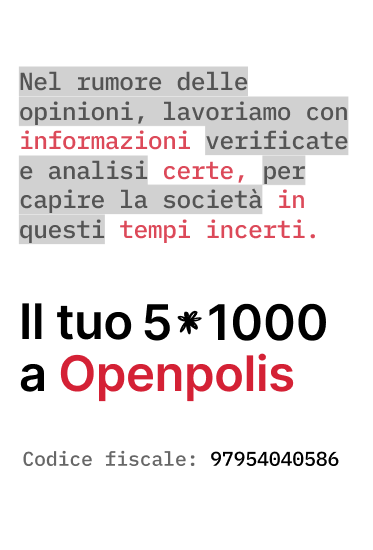Il nostro diritto digitale alla città
6. Lavoratori digitali della citta, unitevi!
di Kurt Iveson (1)
Per un numero sempre maggiori di cittadini, soprattutto nei centri urbani, gli smartphone e le app sono strumenti essenziali per la vita di tutti i giorni.
Scarica il libro gratuitamente o richiedine una copia stampata .
Potrebbe sembrare che le app lavorino per noi ma anche noi lavoriamo per le app.
A seguito della diffusione degli smartphone nell’ultimo decennio, milioni di persone nelle città di tutto il mondo si sono abituate ad utilizzare le app per orientarsi, fare nuove conoscenze, magari rimorchiare, condividere immagini e pensieri ma anche beni materiali, giocare e molto altro.
Potrebbe sembrare che le app lavorino per noi, migliorando la vita nelle città. Credo però che stiamo guardando la cosa dal lato sbagliato – o almeno, guardiamo solo una faccia della medaglia: anche noi lavoriamo per le app.
Quando utilizziamo le app per spostarci in città stiamo svolgendo una sorta di “lavoro digitale” che genera enormi profitti per le corporation che le sviluppano. Per parlare di “diritto alla città” nei nostri luoghi e tempi digitalizzati, dobbiamo pertanto fare un’analisi di come il nostro lavoro digitale venga sfruttato e discutere le strategie di democratizzazione del plusvalore che esso genera.
Vita urbana e lavoro digitale
La connessione tra le app del cellulare ed il “lavoro digitale” potrebbe non essere così evidente: usandole non stiamo semplicemente utilizzando un prodotto o un servizio fornitoci da qualcun altro? Questa interpretazione non è certamente sbagliata, ma per chi possiede queste app, e deve quindi gestirne il modello di business, vederci non solo come utenti ma anche “lavoratori digitali” comincia ad avere più senso.
Se molte delle app di cui diventiamo sempre più dipendenti sono “gratis” non è certo per la bontà di cuore di chi le realizza: se l’app viene offerta a costi bassi o nulli vuol dire che le possibilità di guadagno sono altre. Ma quali?
I dati sugli spostamenti cittadini sono una miniera d’oro per le aziende
Gli annunci promozionali sono sicuramente un “prezzo” da pagare per usare le app, i cui guadagni dipendono dalle entrate pubblicitarie; ma la maggior parte delle app che usiamo per spostarci in città sono progettate per raccogliere dati sui nostri movimenti. I dati sugli spostamenti cittadini – detti anche dati “di localizzazione” o “geospaziali” – sono una miniera d’oro per le aziende che li rivendono ad altri, i quali, a loro volta, li riusano per scopi differenti – ad esempio per creare nuove offerte commerciali, per fare pubblicità mirata oppure offrire informazioni a chi si occupa di sicurezza.
Anche se ottenere delle informazioni chiare sulla compravendita dei dati è decisamente complicato, possiamo farci un’idea del potenziale economico dei dati geospaziali basandoci sul valore di mercato delle app che li raccolgono. Waze, ad esempio, è un’app per la navigazione in tempo reale che raccoglie e condivide i dati sugli spostamenti dei suoi utenti all’interno della rete stradale. Nel 2013 Google l’ha acquisita ad un prezzo dichiarato di 1,3 miliardi di dollari: davvero elevato per un app che si installa e si utilizza “gratuitamente”. È grazie al lavoro degli utenti che l’hanno utilizzata per spostarsi che chi controlla Waze ha potuto rivenderla a una tale cifra.
Waze è una delle tante app che ci mettono al lavoro per raccogliere dati, che ne siamo consapevoli oppure no. Utilizzare queste app nel tempo libero diventa quindi una forma di manodopera, un ingrediente essenziale per il loro valore di mercato. Trebor Sholz è un analista di media digitali secondo il quale “con i dati sulla nostra posizione e sul tracciamento dei nostri movimenti contribuiamo a creare una risorsa economica senza che il nostro lavoro ci venga riconosciuto.”
“Faremo elaborare dai calcolatori elettronici tutti i dati del problema? Perché no?! Tuttavia, la macchina non utilizza che dati che provengono da domande a cui si risponde con “sì” o “no”. Essa stessa non risponde che a domande che vengono poste con un “sì” o con un “no”. Chi oserà pretendere che tutti i dati sono stati raccolti? Chi legittimerà questo impiego della totalità? Chi dimostrerà che il “linguaggio della città”, per poco che ve ne sia uno, coincida con l’ALGOL, il Syntol o il FORTRAN, linguaggi delle macchine, e che questa traduzione non sia un tradimento? Di più, la macchina non rischia di diventare strumento nelle mani di certi gruppi di pressione, di certi politici? Non è forse già un’arma per gli uomini al potere e per i servi dei politici?
Attivarci sul lavoro digitale
Se l’utilizzo quotidiano di smartphone e app sono diventati una specie di lavoro digitale, cosa possiamo fare?
Una parte consistente del dibattito sul diritto alla città informazionale è concentrato sui nostri diritti in quanto consumatori. In questo modo i riflettori rimangono puntati su questioni importanti quali protezione della privacy e termini di servizio associati che sottoscriviamo per usare le app.
Oltrepassare i nostri diritti di consumatori e portare l’attenzione sui nostri diritti di produttori
Una critica completa al lavoro digitale deve però oltrepassare i nostri diritti di consumatori e portare l’attenzione sui nostri diritti di produttori, collegati a questioni fondamentali per la politica e l’economia politica.
Secondo il geografo David Harvey la lotta per il diritto alla città diventa una lotta per “un maggior controllo democratico sulla produzione e sull’utilizzo del plusvalore” a cui contribuiamo quotidianamente utilizzando le app: se vogliamo che le nostre città diventino più eque e giuste, il plusvalore deve essere democratizzato e redistribuito.
I diritti dei lavoratori alla definizione delle condizioni del proprio lavoro e alla socializzazione dei prodotti del lavoro stesso non sono stati ottenuti senza lottare. Quella sul lavoro digitale è sicuramente una lotta contemporanea ma guardare al passato può offrire delle lezioni importanti.
Abbiamo bisogno di nuovi modi per rivendicare i nostri diritti collettivi di lavoratori (oltre ai nostri diritti individuali di consumatori), stiamo assistendo alla nascita di nuove forme di organizzazione per affrontare queste questioni. Possiamo riadattare lo stesso modello sindacale utilizzato in passato per rivendicare e proteggere i diritti dei lavoratori nella situazione attuale? Qualche anno fa un tentativo di creare un Sindacato degli Utenti di Facebook attirò l’attenzione dei media, ma non durò molto. Quali strategie potremmo sperimentare per cooperare come lavoratori digitali?
Abbiamo bisogno anche di metodi per redistribuire collettivamente in maniera più efficace i profitti del nostro lavoro, un risultato che i movimenti lavoratori del passato hanno raggiunto tramite la tassazione. Per quanto la realizzazione di nuove forme di tassazione possa sembrare un obiettivo difficile, è comunque una sfida che vale la pena affrontare se si considera che le agili corporation digitali, che lucrano sul nostro lavoro, non stanno pagando la loro parte.
Note:
(1) Kurt Iveson – Università di Sydney (kurt.iveson@sidney.edu.au)
Traduzione Federico Piovesan – Twitter: @federicopvs