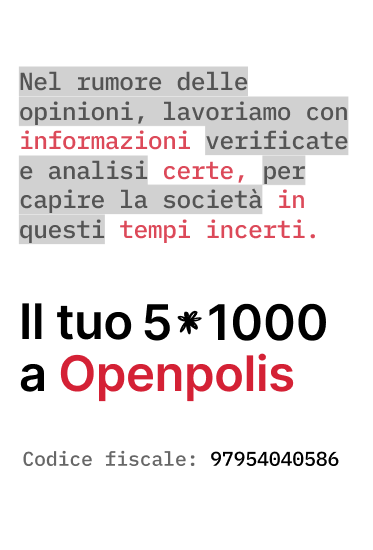Definizione
La legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere le barriere normative per facilitare l’apertura dei mercati ai piccoli imprenditori e tutelare i consumatori. I contenuti della legge sono definiti anche sulla base di analisi – svolte a livello europeo, di autorità amministrative indipendenti nazionali, di associazioni di categoria e altri soggetti istituzionali – che mirano a capire quali siano i settori su cui è necessario intervenire con delle riforme per eliminare gli ostacoli alla libera iniziativa imprenditoriale.
Sul piano nazionale, la concorrenza è materia di competenza dello stato, come disposto dall’articolo 117 della costituzione. Questo, come altri ambiti, deve essere gestito entro i limiti posti dall’ordinamento comunitario. I pilastri principali sono definiti negli articoli che vanno dal 101 al 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfeu). Su queste premesse, si poggia la legge 99/2009 che tra le altre cose introduce la redazione di questa norma annuale.
Il disegno di legge sulla concorrenza è di iniziativa governativa. Deve essere approvato in consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). La proposta è presentata dal ministro per le imprese e il made in Italy che tiene conto delle osservazioni dell’Agcm e della conferenza unificata.
La legge annuale sulla concorrenza rientra tra le riforme del Pnrr.
Anche se una legge di questo tipo dovrebbe essere pubblicata una volta all’anno, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2021 ciò è avvenuto una sola volta, nel 2017. È anche per questo motivo che tali norme sono state inserite tra le riforme da realizzare attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa è stata un’esplicita condizione posta dalle istituzioni europee ai fini dell’approvazione del piano italiano.
La prima legge pubblicata al fine di adempiere agli obiettivi del Pnrr è entrata in vigore il 27 agosto del 2022 e fa riferimento al 2021. La seconda il 31 dicembre del 2023 con riferimento al 2022.
Dati
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, la più recente, si compone di 22 articoli suddivisi in 6 capi. Sono molti gli ambiti di intervento. Tra questi, alcuni dei più rilevanti riguardano il settore degli autotrasporti, modifiche al codice del consumo, misure per l’attuazione del regolamento Ue 2022/1925 relativo al mercato dei prodotti digitali, il diritto d’autore e il rinvio di scadenze in merito alle autorizzazioni paesaggistiche.
L’entrata in vigore della legge era una delle scadenze relative al Pnrr che il nostro paese avrebbe dovuto completare entro la fine del 2023. Nello specifico l’obiettivo era quello di adottare il piano di sviluppo della rete per l’energia elettrica e promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. Obiettivi che sono stati conseguiti attraverso gli articoli 1 e 2 della legge.
La legge sulla concorrenza per il 2022 si compone di 22 articoli
I principali ambiti di intervento della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
FONTE: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
(ultimo aggiornamento: domenica 31 Dicembre 2023)
Non tutte le disposizioni sono immediatamente applicabili. In alcuni casi è necessario il ricorso ai decreti attuativi. Atti di secondo livello (principalmente decreti ministeriali) che servono a definire più nel dettaglio le disposizioni contenute nella legge. Anche l’entrata in vigore di questi provvedimenti coincide con delle scadenze a cui il nostro paese deve adempiere nell’ambito del Pnrr. In base alle informazioni messe a disposizione dall’ufficio per il programma di governo, alla data del 16 gennaio 2024, nessuno dei decreti attuativi richiesti dalla legge per la concorrenza 2022 risulta ancora pubblicato.
3 i decreti attuativi richiesti per la piena implementazione della legge per la concorrenza 2022.
Per quanto riguarda la legge 2021 invece le attuazioni richieste erano 8, di cui 2 mancano tuttora all’appello.
Analisi
Per quanto il Pnrr abbia contribuito perlomeno a far rispettare l’obbligo di pubblicare una legge sulla concorrenza ogni anno, le criticità irrisolte su questo fronte sono ancora molte. Le due leggi entrate in vigore nel 2022 e nel 2023 infatti non hanno affrontato alcuni degli argomenti più divisivi agli occhi dell’opinione pubblica nazionale.
Per quanto riguarda la prima delle due norme ad esempio si è scelto, anche a seguito di proteste non sempre pacifiche, di non affrontare il tema della disciplina del trasporto pubblico non di linea (taxi, noleggio con conducente e forme simili).
Un altro tema certamente problematico è quello legato alle concessioni balneari. Criticità per cui è tuttora in corso una procedura di infrazione a carico del nostro paese. Da questo punto di vista la legge per la concorrenza del 2021 attribuiva al governo la delega per intervenire sul tema con uno o più decreti legislativi. Questo sarebbe dovuto accadere entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge ma non è avvenuto.
I ritardi nell’attuazione di procedure competitive efficaci per l’assegnazione di concessioni marittime, lacustri e fluviali per attività turistico ricreative, così come la limitata redditività di tali contratti di concessione per le autorità pubbliche, rimangono fonte di preoccupazione.
Una criticità simile è emersa anche relativamente alla legge 2022 per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali. L’aspetto critico riguarda l’articolo 11 che dispone la proroga di alcune concessioni in scadenza. Le proroghe in questione – che arrivano anche a 12 anni – peraltro hanno portato a un richiamo formale da parte del presidente della repubblica.
In una lettera inviata a governo e parlamento infatti il capo dello stato ha evidenziato come tale periodo sia estremamente lungo. Incompatibile con la giurisprudenza nazionale ed europea in materia. Inoltre l’inquilino del Quirinale ha anche evidenziato come i criteri individuati per il rilascio di nuove concessioni appaiano restrittivi della concorrenza in entrata. Così favorendo, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti. Per questo il capo dello stato ha auspicato che governo e parlamento tornino a legiferare sul tema in tempi rapidi.
Non esistono informazioni sui risultati ottenuti con la legge per la concorrenza 2021.
Un altro aspetto da rilevare riguarda il fatto che, in base all’articolo 47 comma 4 della citata legge 99/2009, il governo dovrebbe allegare al Ddl per la concorrenza una relazione di accompagnamento che evidenzi, tra le altre cose, lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi. Indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Di questo documento però non si trova traccia per quanto riguarda la legge 214/2023. Né nel testo pubblicato in gazzetta ufficiale né tantomeno nei documenti prodotti durante la discussione in parlamento. In base a quanto riportato dal comitato per la legislazione del senato, il governo ha fornito l’analisi tecnico-normativa e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione. Non è chiaro però se in questi documenti si fa riferimento anche ai risultati già raggiunti. Anche perché non sono consultabili.
Aspetti critici come questo riguardano l’intero piano nazionale di ripresa e resilienza. Senza documenti di questo tipo infatti sarà impossibile valutare l’impatto del piano sul nostro paese e capire se gli ambiziosi obiettivi che si puntava a raggiungere saranno effettivamente conseguiti.